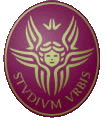
Graduation Thesis/Tesi di Laurea
Antonino Saggio I Quaderni
Sapienza,
Università di Roma, Facoltà di Architettura
Questo progetto fa parte della ricerca della Cattedra di Antonino Saggio
iniziata nel febbraio del 2023in preparazione
Melinda Pierini
PIUMA
Psycological Integration & Unity fo Mental Awarness
AA 24-25 Tesi Discussa il 21 ottobre 2025
Relatore Antonino Saggio
Co-relatore Gaetano De Francesco
Presentazione
*
Brochure
*
***
0. Il progetto che vi presento oggi si sviluppa in due fasi, due piani di lettura complementari che dialogano costantemente tra loro: da un lato una ferita urbana, dall’altro una ferita umana.
1. Ferita urbana intesa come vuoto, come cesura nel tessuto della città, e nasce da una riflessione sulla chiusura dell’Ospedale San Giacomo di Roma un evento che ha lasciato un segno tangibile non solo nella struttura fisica del centro storico, ma anche nella percezione collettiva di un sistema sanitario e sociale che si è improvvisamente interrotto.
2. Il San Giacomo nasce in un’area strategica della città: lontano dal centro abitato e in prossimità del Porto di Ripetta, garantendo facile accesso alle navi di approvvigionamento e assistenza ai pellegrini provenienti dalla Porta del Popolo (allora porta dei Pellegrini). Fu il terzo ad essere edificato nella Roma del Medioevo dopo il Santo Spirito in Sassia e il San Salvatore, diventato poi ospedale di San Giovanni in Laterano. Nel 1519 papa Leone X stabilì la gratuità dell’assistenza a tutti i malati mentre le principali fonti di finanziamento provenivano da donazioni di esponenti di famiglie nobili tra cui il cardinal Salviati che destinò parte della sua eredità alla costruzione, manutenzione e gestione della struttura con il vincolo che venissero rispettate e mantenute nel tempo le sue originarie funzioni. Da allora l’ospedale non hai mai interrotto la sua attività al punto che nel 2003 iniziò una fase di ristrutturazione graduale che procedette un reparto alla volta. Le ultime opere di riqualificazione vennero completate nel luglio del 2008, appena un mese prima dell’annuncio della chiusa motivata dalla Regione Lazio con la difficile situazione del debito sanitario accumulatosi negli ultimi anni. Da quel momento iniziarono esposti, manifestazioni e proteste di comitati e associazioni, insieme all’opposizione degli eredi del cardinal Salviati decisi a far rispettare il vincolo imposto nel 500.
3. Allo stato attuale, mentre continuano i ricorsi al Tar, la struttura versa in uno stato di abbandono con alle spalle 17 anni di mancata manutenzione. Oltre a questo, nel valutarne una sua eventuale rimessa in opera, si deve tener conto del fatto che l’edificio non risulta più compatibile con le esigenze funzionali e spaziali di un ospedale contemporaneo: la sua struttura planimetrica rigida, la mancanza di accessi idonei ai malati acuti, e il dispendio economico ne rendono difficile un suo adeguamento.
Per queste ragioni la proposta è quella di non intervenire sull’esistente ma la valutazione del rapporto economico di dare/avere derivante dalla vendita dell’attuale struttura e dalla sua successiva rilocalizzazione.
4B. La nuova sede verrebbe spostata di soli 800 metri in linea d’aria, inserendosi nel progetto TTline, un programma di rigenerazione urbana che mira a riattivare i vuoti lungo la linea 2 del tram di via Flaminia. L’area individuata è quella di Borghetto Flaminio, una zona che oggi presenta occupazioni abusive, attività improprie e manufatti abbandonati per la quale nel corso degli anni sono state avanzate numerose proposte di trasformazione, nessuna delle quali ha mai previsto funzioni ospedaliere. Proprio per questo motivo, l’ipotesi di reinsediare qui l’ospedale si configura come un’occasione di riflessione per la città, sia nel caso in cui si decida di accoglierla, sia nel caso in cui si scelga di non aderirvi. Da qui la scelta in questa prima fase di non andare oltre rispetto a un’ipotesi di assetto generale di quello che potrebbe essere l’impianto del il piano terra di un ospedale posto in quest’area.
5. A partire da questa nuova collocazione, il progetto trova le proprie matrici generative nello studio approfondito del territorio al fine di costruire un palinsesto urbano, un sistema di relazioni che non si limita a ospitare un nuovo edificio, ma che attraverso di esso fa emergere i diversi strati della città, visibili e non: le curve di livello della rupe che definiscono la morfologia naturale del terreno, le falde acquifere che dal crinale scendono verso il fiume costruendo una trama sotterranea di flussi vitali, il tessuto urbano fatto di pieni e di vuoti, e infine i confini di esondazione, segno mutevole e al tempo stesso identitario del rapporto tra Roma e l’acqua. Questi elementi diventano le componenti fondative del progetto, veri e propri dispositivi generativi che orientano le scelte compositive, distributive e spaziali.
6. Da qui inizia la seconda fase del lavoro che affronta invece la ferita umana, legata al tema della fragilità psicologica contemporanea. Il progetto scende nel dettaglio specializzando un’ala dell’ospedale come centro di supporto psicologico per adolescenti con disturbi mentali minori.
Negli ultimi anni un’atmosfera d’instabilità e incertezza senza precedenti ha permeato l’Italia e l’Europa influenzando profondamente la salute mentale della popolazione che molto spesso però non risulta esserne consapevole. Come emerge da alcuni dei dati raccolti infatti se il 28% degli italiani dichiara di aver sofferto di una qualche forma di malessere o disturbo mentale il 33% invece sono quelli sospettati di soffrire di disturbi mentali che non hanno visto un medico. Questo spesso è legato anche alle difficoltà incontrate durante l’accesso ai servizi di salute mentale: lunghe liste di attesa, costi elevati delle cure, mancanza di specialisti, paura di medici e ospedali.
Dalle analisi effettuate emerge però che le criticità maggiori riguardano i più giovani, sia perché la maggior parte dei disturbi mentali si manifestano prima dei 18 anni sia perché si trovano in uno scenario in cui numerose e grandi crisi si accumulano e si amplificano a vicenda:
Il covid-19, la violenza tra i giovani, l’eco-ansia sono solo alcune di queste.
L’impatto che questo problema ha nella società è evidenziato anche dagli obiettivi globali che ne sono scaturiti e che riguardano soprattutto la prevenzione:
Nel PIANO D’AZIONE PER LA SALUTE MENTALE L’OMS definisce azioni chiare per promuovere a livello globale salute mentale e benessere, prevenire l’insorgenza di disturbi mentali in popolazioni a rischio e raggiungere una copertura universale per i servizi di salute mentale
Mentre nell’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE Gli obiettivi numero 3 e 11 si propongono di garantire la salute e promuovere il benessere per tutti a tutte le età, focalizzandosi su diversi ambiti di intervento tra cui la promozione di benessere e salute mentale
Oggi la salute mentale è spesso trattata in spazi inadeguati, rigidi o distanti dalla vita quotidiana, e mancano luoghi in grado di offrire un’esperienza di accoglienza e ascolto.
Il progetto PIUMA nasce dall’esigenza di ripensare lo spazio di cura come strumento attivo nel processo terapeutico, superando il modello tradizionale di struttura sanitaria per proporre invece un ambiente empatico, fluido e rigenerante, capace di favorire equilibrio, benessere e consapevolezza. L’idea alla base è quella di creare un centro integrato di supporto psicologico e medico, dove la persona possa sentirsi accolta e protetta, in un contesto architettonico che trasmetta leggerezza, calma e connessione con la natura. Il nome stesso, PI.UMA, è un acronimo ma anche una metafora: come una piuma, la struttura vuole essere leggera ma solida, delicata ma presente, e soprattutto in grado di accompagnare l’utente in un percorso di cura che coinvolge mente, corpo e percezione sensoriale. L’architettura diventa così strumento terapeutico: la forma, la luce e i materiali non sono elementi puramente estetici, ma componenti fondamentali del processo di guarigione.
il progetto è limitrofo a quelli pubblicati nel libro
Tevere Cavo
a cura di Antonino Saggio Gaetano De Francesco
Urban green line progetti sistemici per una infrastruttura ecologica a roma
UrbanVoids is the book that explains the urban infill strategy to which this project belongs to.
Roma a_venire is the book that collects twenty and more design projects and explains the overall urban, social and design strategy to which this project belongs to.
L'Arca # 278 , International Architectural magazine published the strategy of the Urban Green Line and this this project-
Tevere cavo, una infrastruttura di nuova generazione a Roma tra pasato e futuro
Antonino Saggio Home| Teaching activity a "La Sapienza" Rome